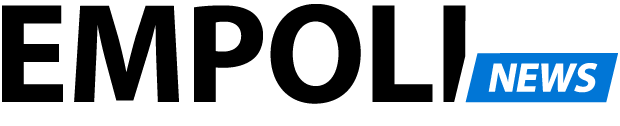“Fantasmi”, s’intitola così il nuovo romanzo dell'empolese Fabio Casalini: un insieme di fatti e intrecci che si risolveranno non ricorrendo alla classica figura del detective, non c’è spazio per una figura del genere, ma attraverso un disvelamento per i personaggi di vicissitudini che sfuggono all’evidenza della razionalità, fino al punto in cui sarà la casualità a decidere le sorti del racconto. Il detto “Se non vedo non credo” decade, sarà necessario infatti abbandonare la fiducia nella luce per indagare sulla misteriosa morte di una donna e sua figlia. Infatti il protagonista coinvolto nella storia sarà trascinato in un vortice di “flashback, sedute di ipnosi, psicoterapia e aspettative personali, diventando lo spettatore inerme di quello che lo circonda, muovendosi in un mondo privo di appigli, di punti di riferimento, di una stella polare.
Come sottolinea Casalini, nel corso della nostra intervista “Fantasmi” è lo sviluppo sotto forma di romanzo, di uno dei racconti brevi della raccolta: Aristoon. Una storia d’amore in cui il richiamo al “Mito della Caverna” di Platone (VII libro de La Repubblica) e al dualismo tra doxa ed epistème, è forte e chiaro. Ringraziamo l’autore Fabio Casalini quindi per aver risposto ad alcune delle nostre domande per capire meglio “Fantasmi”.
Fabio, grazie per la tua disponibilità. Innanzitutto, quando e come nasce “Fantasmi”, uscito da pochissimo?
Fantasmi nasce dalla mia passione per due generi apparentemente separati: il thriller e la letteratura filosofica. Nello specifico la sua ideazione prende forma nell’estate del 2023, momento in cui arrivava al culmine la mia riflessione su alcuni fatti vissuti nei tre anni precedenti e che si era arenata in un circolo vizioso pieno di contraddizioni lasciandomi di fatto senza una risposta soddisfacente. Fantasmi è il tentativo di dare la parola a questo groviglio inestricabile.
Ci puoi raccontare in breve di cosa parla?
Fantasmi parla dell’ignoranza come costituente della natura umana. Un ignoranza epistemologica, esistenziale ma anche emotiva. Tutto questo viene declinato attraverso quello che è considerato uno dei cardini della vita delle persone: l’amore. “Fantasmi” è prima di tutto una storia d’amore.
Nel disvelamento dell’indagine che peso hanno logica, pensiero e intuizione?
La storia (e quindi l’indagine) si dipana attraverso una serie di fatti che in qualche modo sfuggono alla razionalità, fino al punto in cui le sorti del racconto si decidono su veri e propri eventi casuali. Il messaggio di Platone è chiaro: quello che l’uomo vede non sono gli oggetti reali ma immagini distorte e fluttuanti che ne ricalcano il profilo. Su questo sfondo non c’è spazio per il classico detective che avanza a colpi di inferenza deduttivamente esatta.
Sebbene, ovviamente, la struttura di questo lavoro (romanzo) e il tuo lavoro precedente “Racconti d'amore e morte” (raccolta di racconti) sia differente, cosa li differenzia a livello di personaggi, svolgimento e modalità di indagare luci e ombre?
La differenza con la raccolta dei racconti sta solo nella lunghezza. Forse anche nel fatto che il racconto breve si presta ad una scrittura talvolta quasi poetica, ma nella sostanza lo stile credo resti invariato. Anzi, “Fantasmi” è lo sviluppo sotto forma di romanzo, di uno dei racconti brevi della raccolta: Aristoon.
Quali sono i riferimenti al mondo della filosofia all’interno del romanzo?
L’omaggio a Platone è evidente. Insieme a lui ci sono molti altri riferimenti a partire da Cartesio, Schlick, Zipoli Caiani e altri.
Quanto ha influito il tuo ritiro in Casentino sulla tuo visione delle cose?
L’esperienza taoista ha certamente influenzato la mia tendenza a prediligere spiegazioni dicotomiche (yin yang) o comunque difficilmente comunicabili (il vero Tao non è nominabile, se è nominabile non è vero Tao).
Un’ultima domanda.
Secondo te nella società odierna com’è possibile decodificare il linguaggio e il pensiero filosofico? Come si colloca la filosofia oggi? Serve ancora il pensiero filosofico e come può secondo te accompagnare l’individuo?
Ti rispondo con Wittgenstein: nel “Tractatus” sosteneva che la filosofia serve a chiarire i concetti e a risolvere le confusioni linguistiche, disvelando i limiti del linguaggio e del pensiero. La filosofia, secondo lui, non risponde a domande metafisiche o teoretiche, ma si limita a rendere chiari i significati e i giochi di linguaggio che usiamo nella vita quotidiana. In sostanza, semplificando, sosteneva che la filosofa allenasse il pensiero. È chiaro che un’attività di tale tipo non potrà mai divenire né inutile né obsoleta ma anzi, all’interno di una società sempre più complessa come la nostra diventa una forma di attività quasi necessaria.